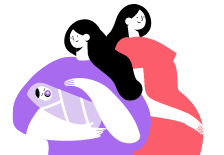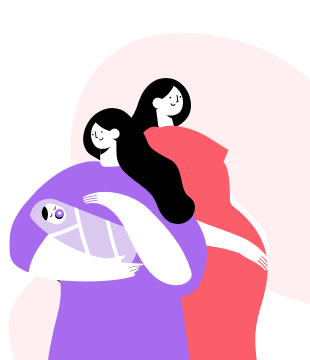Le nostre nonne (e anche qualche mamma, probabilmente) partorivano senza neanche sapere il sesso del bimbo che portavano in grembo. Figuriamoci quindi se potevano sapere se qualcosa non andava per il verso giusto. Col tempo, nel campo della diagnosi prenatale sono stati fatti passi da gigante e ora ogni futura mamma può sapere molte cose sullo stato di salute del feto. “Va detto però – sottolinea Giuseppe Rizzo, presidente della Sieog, la Società italiana di ecografia ostetrica e ginecologica – che il 100 per cento di precisione delle diagnosi è impossibile”.

Prof. Giuseppe Rizzo
Professore Rizzo, com'è cambiata negli anni la diagnosi prenatale? Cosa consentiva di scoprire in passato e fino a dove può giungere ora?
“Le novità più importanti sono state due. Innanzitutto, il progressivo spostamento della diagnostica dal secondo al primo trimestre, tra l'11esima e la 14esima settimana. Questo è il periodo in cui si possono iniziare a riscontrare i problemi. E, in secondo luogo, la possibilità di effettuare meno esami diagnostici invasivi in favore di tecniche meno invasive per valutare le diverse condizioni di salute del feto, quali il test combinato (bitest) e la ricerca nel sangue materno del DNA libero del feto (NIPT). Con molti vantaggi anche per la mamma. C'è però una questione di tipo economico da sottolineare perché gli attuali Lea (i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni a carico del Sistema sanitario nazionale, ndr) non prevedono questi esami. Quelli in corso di approvazione prevederanno il test combinato, ma non il NIPT. Questi test comunque hanno delle ombre: esistono infatti falsi positivi e falsi negativi e non tutte le donne possono effettuarli. L'affinamento di questi test e le tecnologie sempre più avanzate rendono auspicabili dei miglioramenti”.
Perché la Sieog, la Società italiana di ecografia ostetrica e ginecologica, ha ritenuto importante dotarsi di specifiche linee guida?
“Questo è uno dei compiti istituzionali delle società scientifiche. Il concetto è quello di garantire un minimo comune denominatore nelle prestazioni, così una donna sa che almeno può avere un minimo garantito. Ovviamente poi questi standard di base possono essere superati. Ma le linee guida costituiscono una sicurezza sia per gli operatori che per le donne”.
A questo proposito, come fa una futura mamma ad essere sicura che si sta affidando a personale competente e altamente preparato a praticare le principali tecniche di diagnosi prenatale?
“Purtroppo non esistono un registro o delle strutture che possano certificare le competenze, né delle norme che lo impongono. Questo è un limite della nostra legislatura rispetto ad altri Paesi. Quindi, se la certificazione non c'è, ci si deve affidare alla responsabilità personale degli operatori. Sono state fatte varie proposte per cercare di avere una normativa ad hoc, ma finora senza risultato. Negli Stati Uniti ed in altri stati europei invece viene fatta una certificazione periodica del personale. In Italia c'è soltanto qualche iniziativa sporadica di Asl particolarmente virtuose”.
Gli esperti sostengono che siano sufficienti tre ecografie durante la gravidanza, chiaramente se non ci sono particolari complicanze. Eppure, capita che molte donne ne facciamo praticamente una al mese, durante la consueta visita dal ginecologo. Come giudica questa pratica?
“Prima di tutto dobbiamo distinguere le ecografie diagnostiche da quelle di sostegno alla visita ('office'). Ormai l'ecografo è entrato negli ambulatori. Viene usato anche dalle ostetriche. Vengono fatte ad esempio per accertare la gravidanza o la posizione del feto. Non vanno però considerate di screening, ma di supporto. I Livelli essenziali di assistenza prevedono tre ecografie. In futuro potrebbe scomparire quella del terzo trimestre e dovrebbe esserne aggiunta una precoce, a 7-8 settimane. Quindi rimarrebbero in ogni caso tre”.
Quando sono davvero necessarie tecniche di diagnosi prenatale invasive come la villocentesi e l'amniocentesi?
“Si tratta di due metodiche insostituibili. La cosa importante è che siano fatte da mani esperte, soprattutto nel caso della villocentesi. In questo modo la percentuale di rischio è più bassa. Devono farle le pazienti a rischio, ad esempio con una storia di talassemia o i test non invasivi positivi. Amniocentesi e villocentesi non vanno fatte a tappeto, ma soltanto nella popolazione a rischio”.