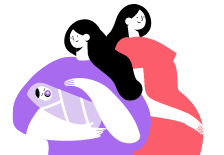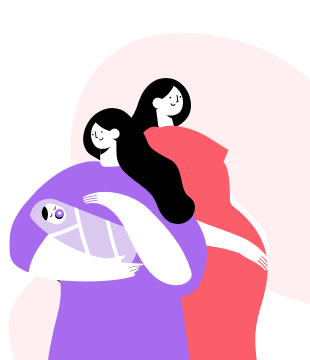Contents
Che la gravidanza sia un periodo meraviglioso è fuor di dubbio. Quante emozioni ci sono nel viaggio verso la maternità! Di contro però è innegabile che questa strada sia spesso costellata da una serie di piccoli o grandi disturbi che a volte la rendono un po’ più tortuosa. Tra nausea e vomito, mal di schiena, capogiri, pressione “ballerina” e stanchezza, non sempre c’è da stare allegre. E non abbiamo menzionato uno degli “incidenti di percorso” più antipatici: le emorroidi in gravidanza. Ecco di cosa si tratta e cosa si può fare per cercare di prevenirle.
Cosa sono le emorroidi
Partiamo da una notizia che forse non vi aspettate: tutti abbiamo le emorroidi. “Ma com’è possibile? Mai avute in tutta la mia vita!”, starete pensando. Non è così e ora vi spieghiamo il motivo. Le emorroidi non sono altro che cuscinetti venosi che si trovano a cavallo dell’orifizio anale. La loro funzione è quella di contribuire alla sua continenza. Capito perché ciascuno di noi le ha?
In una situazione normale, le emorroidi non dovrebbero essere un problema. Quindi è sbagliato affermare di “soffrire di emorroidi” perché quando sono in salute non fanno male, non sanguinano, non prudono, non sono infiammate. In altre parole, nemmeno si sentono! Quando invece si verifica tutto ciò si parla di patologia emorroidaria, espressione che indica la presenza di vene ipertrofizzate (cioè che si gonfiano), scatenano disturbi e, in alcuni casi, fuoriescono dall’ano.
Tipi di emorroidi
Le emorroidi possono essere essenzialmente di due tipi:
- interne: sono localizzate nel canale anale, sono indolori e non sono visibili. Se con la defecazione tendono a fuoriuscire dall’ano, poi rientrano da sole.
- Esterne: situazione opposta con emorroidi al di fuori dell’ano e dolorose. Non rientrano spontaneamente oppure sono sempre all’esterno del canale anale.
A seconda della severità della sintomatologia, la patologia emorroidaria può essere di 4 stadi differenti. I primi due sono quelli meno importanti (quindi con emorroidi interne o che tornano al loro posto da sole, non particolarmente dolorose), mentre il terzo e il quarto sono i più seri. Ovviamente il trattamento varia a seconda dello stadio delle emorroidi, andando da rimedi più semplici come gli impacchi o le creme topiche fino all’intervento chirurgico.
Fattori di rischio
Alcuni fattori di rischio predispongono all’insorgenza della patologia emorroidaria:
- gravidanza (non a caso le donne sono quelle più colpite).
- Familiarità.
- Stipsi.
- Stile di vita.
- Obesità.
- Insufficienza venosa cronica in generale.
In particolare, alcune abitudini hanno un ruolo fondamentale nella comparsa dei sintomi: una dieta povera di fibre e di acqua, la sedentarietà, lavori che obbligano a stare molto tempo in piedi o a fare sforzi, sono degli esempi. E, come vedremo, è proprio qui che si deve intervenire per giocare d’anticipo e fare prevenzione.
Cause delle emorroidi in gravidanza
I primi riferimenti storici alla malattia emorroidaria sono molto antichi e risalgono a oltre 4.000 anni fa in Mesopotamia. Oggi è la patologia anorettale più frequente in gravidanza e nel puerperio, cioè il periodo che segue il parto. Il rischio di soffrirne è maggiore del 30% nelle donne con gravidanze successive alla prima (multiparità).
Le emorroidi in gravidanza sono provocate da un mix di diversi elementi. Per vari motivi, una serie di cambiamenti fisiologici, meccanici e ormonali aumenta la sollecitazione sulla zona anale facendo ingrossare le emorroidi e dando di conseguenza i disturbi. Inoltre, se questi erano presenti già prima di rimanere incinta, col pancione i sintomi potrebbero presentarsi precocemente ed essere più acuti.
Emorroidi inizio gravidanza
Le emorroidi ad inizio gravidanza derivano prevalentemente da cause ormonali. L’organismo produce quantità elevate di estrogeni, specialmente di progesterone che, tra i suoi vari effetti, comporta una maggiore lassità dei tessuti venosi. Ciò fa sì che il sangue ristagni nei vasi, anche a livello anale. In più, l’aumento del flusso sanguigno, necessario per far fronte alle esigenze di mamma e bambino, aumenta il carico sulle vene, contribuendo alla comparsa della patologia emorroidaria.
Emorroidi in gravidanza avanzata
I disturbi connessi alle emorroidi sono più comuni nel secondo e terzo trimestre. Le ragioni sono molteplici:
- il peso del feto fa pressione sul pavimento pelvico.
- L’utero cresce di dimensione e schiaccia la vena porta e i vasi sanguigni rettali e anali.
- La stitichezza può comparire o peggiorare.
- In generale, la circolazione del sangue è più difficoltosa.
- La parte finale dell’intestino viene spinta verso il basso.
- Spesso l’attività fisica è limitata o del tutto inesistente.
Emorroidi dopo il parto
Chi ha problemi con le emorroidi in gravidanza teme moltissimo il momento del parto perché sa che le spinte potrebbero peggiorare la situazione. Ma la questione può interessare anche chi non soffre di patologia emorroidaria durante la gestazione. All’inizio abbiamo detto che tutti abbiamo questi cuscinetti venosi nella parte interna dell’ano. Una fase espulsiva prolungata può comportare la loro fuoriuscita. La buona notizia è che di solito i sintomi regrediscono naturalmente qualche tempo dopo il parto.
Sintomi delle emorroidi in gravidanza
Quando si aspetta un bambino e dopo aver partorito i sintomi più comuni delle emorroidi ingrossate sono il dolore e il sanguinamento. Il primo ha vari livelli, che vanno dalla sensazione di peso (aggravato dalla stitichezza), prurito e bruciore, a dolore molto acuto all’evacuazione o in caso di prolasso all’esterno dell’orifizio anale.
Il dolore causato da emorroidi in gravidanza non può che influenzare negativamente la qualità di vita di chi lo prova. A volte diventa così invalidante da far rinunciare anche ad attività piacevoli come una passeggiata o una gita con gli amici. Talvolta interferisce anche con il lavoro o il riposo notturno.
Il sanguinamento può essere abbondante oppure invisibile. Difficilmente arriva a provocare carenze a livello ematico (ad esempio, anemia) però va certamente tenuto sotto controllo. Generalmente il sangue delle emorroidi è rosso vivo perché deriva dall’ultimo tratto del canale intestinale.
Emorroidi in gravidanza: rimedi
In gravidanza, il trattamento della malattia emorroidaria è per lo più di tipo conservativo e finalizzato al sollievo dai sintomi. In linea di massima, le terapie o gli stratagemmi da attuare non differiscono da quelli proposti a chi non è incinta, ma alcuni farmaci potrebbero non essere adatti in gravidanza. Inoltre, la chirurgia viene valutata soltanto dopo aver partorito.
Cosa fare se le emorroidi in gravidanza si infiammano? Vediamo qualche rimedio.
- Curare attentamente la propria igiene intima: soprattutto dopo aver evacuato, è importante lavarsi sempre con acqua tiepida e detergenti specifici o a Ph neutro.
- Quando si va in bagno, tamponare la zona anale con qualcosa di morbido (ad esempio, dei quadrati di cotone o salviettine umidificate) al posto della carta igienica.
- Aumentare la quantità di fibre che si assumono con l’alimentazione e bere almeno 2 litri di acqua al giorno: la stitichezza è legata a filo doppio con la patologia emorroidaria. Intervenire su di essa significa migliorare anche la condizione delle emorroidi.
- Applicare ghiaccio per ridurre gonfiore e dolore.
- Anche gli impacchi possono ridurre i sintomi. Ad esempio, potete utilizzare aloe, camomilla o calendula, che hanno proprietà calmanti. Fateli bollire in acqua e, quando intiepidisce, imbevete un panno morbido e tenetelo per una decina di minuti sulla parte dolente.
- Un’alternativa possibile è il cosiddetto semicupio: si riempie il bidet di acqua tiepida e si aggiungono degli oli essenziali (ad esempio di lavanda o ginepro). Si deve immergere il perineo per circa 15-20 minuti, in particolare dopo l’evacuazione.
- Fare un po’ di movimento: passeggiate, nuoto, yoga, ginnastica dolce, ma anche esercizi per potenziare il pavimento pelvico possono essere di grande aiuto.
- Se il dolore è molto forte, utilizzare cuscini speciali per stare sedute: sono progettati per diminuire la pressione sulla zona anale.
- Rivolgersi al ginecologo per i farmaci: alcune creme per emorroidi in gravidanza possono essere usate. Funzionano come anestetici locali e antinfiammatori. Molti prodotti sono a base di bioflavonoidi, principi attivi che hanno effetti benefici sul ristagno di sangue e sul tono venoso. Altri invece sono cortisonici.
Come prevenire le emorroidi in gravidanza
Considerato che la patologia emorroidaria è veramente sgradevole, per non dire insopportabile, riuscire a prevenirla è importante. A maggior ragione durante la gravidanza, se si considera che alcune terapie farmacologiche non possono essere prescritte, così come altre tecniche usate nei casi più complessi non sono consigliate (per esempio, la cauterizzazione con crioterapia o con laserterapia oppure l’asportazione chirurgica).
La prevenzione delle emorroidi in gravidanza si basa fondamentalmente sull’adozione di una serie di comportamenti virtuosi. Primo fra tutti, il contrasto alla stitichezza. Si è infatti visto che c’è una stretta correlazione tra la stipsi (frequentissima in gravidanza per varie ragioni) e la malattia emorroidaria.
Ci sono tante cose che si possono fare contro la stitichezza. Cominciamo dalla tavola. Due regole d’oro: privilegiare alimenti ricchi di fibre (frutta, verdura, cereali integrali), evitando quelli astringenti (riso, banane, carote, mele sbucciate, patate) e bere molta acqua (almeno un litro e mezzo-due al giorno).
L’attività fisica non va assolutamente trascurata perché è utile a favorire la regolarità intestinale. Chiedete al vostro ginecologo quali sono i migliori sport in gravidanza. Non prendete iniziativa autonome per quanto riguarda tisane, lassativi o purganti: anche in questo caso il parere del medico è indispensabile.
Tornando all’alimentazione, ci sono alcuni cibi da evitare per prevenire le emorroidi: sono quelli che contengono molti grassi oppure che possono causare irritazione e infiammazione delle pareti intestinali. Facciamo degli esempi: cioccolato, alimenti piccanti, troppo salati o fritti, alcuni vegetali come pomodori, melanzane e peperoni, formaggi stagionati e fermentati, crostacei e molluschi, dolci, bibite gassate, alcolici. Viceversa, sono da preferire frutta e verdura, pasta e riso integrali, latte e formaggi freschi, olio extravergine d’oliva, carni bianche o magre, pesce.
Ricordate infine l’importanza di fare un po’ di movimento. E in ultimo – ma non per importanza – non bisogna mai trattenere le feci quando si avverte lo stimolo ad evacuare. Non si fa altro che aumentare la pressione sulle vene della regione anale, con il risultato che i sintomi peggiorano.
Le informazioni pubblicate in questo articolo non si sostituiscono al parere del medico. Ti invitiamo a consultarlo in caso di dubbi o necessità.